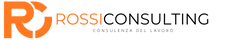Il contratto di rete come strumento di crescita aziendale e la gestione condivisa del costo del personale
L'introduzione nel sistema giuridico italiano del "contratto di rete tra imprese" è avvenuta tramite l'articolo 3, comma 4 ter, del Decreto Legislativo del 10 febbraio 2009, numero 5, successivamente convertito con modifiche dalla legge del 9 aprile 2009, numero 33.
Quest'ultima definisce il contratto di rete come un accordo attraverso il quale vari imprenditori mirano a incrementare sia individualmente che collettivamente la propria capacità di innovazione e competitività nel mercato.
Partecipanti al contratto di rete
Inizialmente, il contratto di rete poteva essere stipulato tra entità imprenditoriali di varia natura giuridica e dimensione - incluse società di capitali, società di persone, cooperative e consorzi, indipendentemente dalle loro dimensioni (grandi, medie e piccole imprese).
Una modifica legislativa successiva (articolo 12, comma 21, della legge numero 81 del 2017, nota come Jobs Act dei lavoratori autonomi) ha esteso la possibilità di aderire a contratti di rete anche a liberi professionisti e altri soggetti esercenti professioni (regolamentate o meno), senza limitazioni relative alla forma giuridica.
Questo cambiamento ha permesso a tali professionisti di partecipare attivamente nelle reti d'impresa, dando vita a quelle che sono state denominate reti miste, conformemente all'articolo 3, comma 4 ter e seguenti, del Decreto Legislativo numero 5 del 2009, come modificato dalla legge numero 33 del 2009.
Fondamenti e cooperazione nel contratto di rete
il programma condiviso
Una componente cruciale del contratto di rete è rappresentata dal "programma condiviso di rete". Questo programma è il fondamento su cui i firmatari si impegnano a collaborare secondo modalità e in settori specifici che riguardano l'attività delle loro imprese.
Questa collaborazione può avvenire attraverso lo scambio di informazioni o servizi in ambito industriale, commerciale, tecnico o tecnologico, o persino attraverso la gestione congiunta di una o più attività che fanno parte dell'oggetto sociale della loro impresa e/o professione.
Oltre a ciò, il contratto di rete può stabilire la creazione di un "fondo comune di patrimonio" destinato a supportare le iniziative congiunte e prevedere la designazione di un "organo comune" responsabile della gestione, in nome e per conto dei partecipanti, dell'attuazione del contratto o di specifici aspetti o fasi dello stesso.
Finalità e Benefici della Rete d'Impresa
L'istituzione di una rete d'impresa mira, fra gli altri obiettivi, a espandere le dimensioni delle aziende partecipanti, potenziare la loro capacità di innovazione e aumentare la loro competitività, sia nel mercato nazionale che in quello internazionale, preservando al contempo l'autonomia legale e operativa delle società coinvolte.
Inoltre, l'adesione a una rete permette di allargare l'offerta di prodotti e servizi e di ripartire i relativi costi, ottenendo così un vantaggio competitivo nel contesto del mercato globale attuale.
Infine, far parte di una rete d'impresa facilita la gestione flessibile del personale, permettendo il distacco dei lavoratori tra le aziende o l'assunzione diretta di dipendenti in un quadro di codatorialità, secondo le modalità definite nel contratto di rete.
Classificazioni delle Reti d'Impresa
Per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi stabiliti, inclusi gli effetti sulla gestione del personale, è possibile identificare due principali configurazioni giuridiche di "rete d'impresa", distinte come segue:
- Rete soggetto: che comporta la formazione di un nuovo soggetto giuridico;
- Rete contratto: che si basa su un modello contrattuale "puro".
Rete soggetto
Nel caso in cui la rete si dota di un patrimonio comune, essa può ottenere personalità giuridica attraverso la registrazione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella circoscrizione dove ha sede.
Questa registrazione conferisce alla rete d'impresa lo status di nuovo soggetto di diritto, denominato rete-entità, permettendole di acquisire una specifica rilevanza anche sotto il profilo fiscale.
Ciò significa che diventa un soggetto autonomo ai fini tributari, soggetto all'imposta sul reddito delle società e a tutti i relativi obblighi tributari diretti e indiretti previsti dalla legge.
Orientamenti dell'Agenzia delle Entrate sulle Reti d'Impresa
L'Agenzia delle Entrate, mediante la circolare del 18 giugno 2013, n. 20/E, chiarisce che le reti-entità possono essere classificate come enti commerciali o non, a seconda che conducano principalmente o esclusivamente attività di natura commerciale.
Questa distinzione determina l'applicabilità delle norme specifiche per ciascuna categoria riguardo alla fiscalità.
Dal punto di vista dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), l'essere considerati soggetti passivi implica l'assegnazione di un numero di partita IVA dedicato e l'obbligatorietà di rispettare gli adempimenti fiscali correlati.
Inoltre, essendo soggette all'Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche (articolo 13, D.P.R. n. 600/1973), queste reti sono tenute alla gestione accurata delle scritture contabili.
È importante sottolineare che i rapporti intercorrenti tra le imprese aderenti e la rete assumono una connotazione partecipativa, paragonabile a quella che intercorre tra i soci e le società in senso più ampio.
Rete Contratto
A differenza delle reti-soggetto, la rete contratto non acquisisce personalità giuridica o tributaria, per cui l'adesione a tale accordo non altera né estingue la soggettività tributaria delle aziende che vi partecipano.
In questa configurazione, la proprietà di beni, diritti e obblighi, nonché la titolarità degli atti, sono attribuibili proporzionalmente alle singole imprese membro, anche se l'organo comune può rappresentarle collettivamente nei confronti di terzi.
Nel contesto di una rete contratto, l'eventuale fondo comune di beni e diritti è inteso esclusivamente a supportare la realizzazione degli obiettivi condivisi, configurando i rapporti tra i partecipanti e l'organo comune secondo la logica di "mandato con rappresentanza".
Aspetti Fiscali
Dal punto di vista fiscale, i costi e i ricavi derivanti dalla partecipazione a un contratto di rete sono trattati in modo da essere deducibili o tassabili in base alle norme impositive applicabili ai singoli membri, secondo quanto previsto dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
È importante notare che ogni azienda parte della rete, inclusa l'eventuale figura della "capofila", è tenuta a redistribuire costi e ricavi tra i membri per i quali ha agito, emettendo o ricevendo fatture per la quota parte imputabile ad altre imprese, a prescindere dalla presenza di un organo comune con potere di rappresentanza.
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 30 giugno 2011, n. 70/E, ha specificato che anche la rete contrattuale può essere registrata nell'anagrafe tributaria ricevendo un proprio codice fiscale.
Questo chiarimento sottolinea che l'iscrizione è permessa anche a entità prive di personalità giuridica, come organizzazioni di persone o di beni.
Nel prossimo articolo, parleremo in maniera più approfondita della gestione dei lavoratori dipendenti nell’ambito delle reti d’impresa e degli aspetti fiscali per i quali illustreremo i riaddebiti di spesa inerenti il personale.
CdL Roberto Rossi