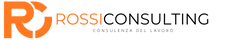Inquadramento della fattispecie
L’interposizione di manodopera è sempre stata considerata con disfavore dal Legislatore che ha nel corso degli anni emesso varie misure normative volte a contrastarla.
Attualmente l’interposizione di manodopera è consentita solo nei limiti stabiliti da un valido contratto di somministrazione di lavoro. Al di fuori di tali limiti ricorre l’ipotesi di somministrazione irregolare di lavoro.
Per valutare la genuinità di un contratto d’appalto si deve partire dalla definizione generale contenuta nell’ art. 1655 del Codice civile secondo cui “l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Questa norma va coordinata con quella contenuta nell’art. 29, co. 1, del D.Lgs. n. 276/2003 in virtù della quale “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.”.
Dal raffronto delle due norme si evince, quindi, come per parlare di appalto genuino siano necessari da parte dell’appaltatore:
1) l’organizzazione di mezzi, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto;
2) l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto;
3) l’assunzione del rischio d’impresa.
Come insegna la Corte di Cassazione (da ultimo, con ordinanza n. 4828 depositata il 16.02.2023) deve essere esclusa la genuinità dell'appalto, quando difetti un’organizzazione d’impresa impiegata nello stesso e sia, invece, riferibile alla committente il concreto esercizio del potere direttivo sui lavoratori formalmente dipendenti dalla appaltatrice.
La Cassazione, nella pronuncia richiamata, precisa che, nel caso di attività esplicate all'interno dell’azienda dalla committente, il divieto dell’utilizzo dell’appalto opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione dell’appaltante solo una prestazione lavorativa.
La giurisprudenza già richiamata ha chiarito come il divieto di somministrazione di manodopera operi – in sostanza - tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo
L’appalto è “genuino” quindi soltanto quando l’appaltatore non risulti essere un intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che, in quanto tale, impieghi la propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi della realizzazione dell’opera o del servizio concordato.
L’appalto, invece, maschera una interposizione illecita di manodopera, quando l’interposto si limita a mettere a disposizione del pseudo committente le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti.
Riflessi penali nell’utilizzo di manodopera
L’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 D lgs 74/00
La dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione è una patologia che può avere significative conseguenze non soltanto sul piano giuslavoristico ma anche di natura penale.
È recentissima la novella dell’art. 18 del D Lgs 276/2003 da parte dell’art. 29, co. 4, del D.L. n. 19/2024, (in vigore il 2 marzo 2024) che ha modificato le conseguenze sanzionatorie della c.d. “somministrazione fraudolenta“ e ha riportato la fattispecie all’interno dell’originaria previsione del Decreto Biagi.
Per effetto di questa modifica all’ art. 18 del D.Lgs. 276/2003 è stato aggiunto il comma 5-ter secondo cui “Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione”.
Va sottolineato come la giurisprudenza penalistica stia concentrando sempre più l’attenzione repressiva verso i fenomeni di fraudolenza nella gestione della esternalizzazione di manodopera e nelle varie ipotesi di somministrazione illegittima (si pensi ad alcuni recenti casi nel settore della logistica e distribuzione); i vertici delle società appaltatrici sono quindi indagati per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D Lgs 74/00) perché hanno mascherato attraverso un contratto d’appalto, apparentemente genuino, acquisizioni illecite di manodopera.
La Sezione tributaria della Corte di Cassazione (sentenza n. 16302 depositata il 27 gennaio 2022) ha chiarito che, in caso di accertamento del carattere fraudolento dell'intermediazione di manodopera, l'IVA che il committente assume di avere pagato al preteso appaltatore per l'operazione soggettivamente inesistente - in quanto corrisposta ad un soggetto che non era legittimato ad operare la rivalsa in ragione del divieto di intermediazione e del carattere fraudolento dell'operazione negoziale - non è detraibile ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, proprio per il fatto che l'alterazione del meccanismo di riscossione dell'imposta in questione, attraverso la realizzazione di comportamenti illeciti dei contribuenti, non consente il dispiegamento dell'ordinaria operatività del diritto alla detrazione dell'imposta sulle operazioni passive dell'imprenditore o del professionista.
A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato come nell'interposizione di manodopera, se vi è illiceità dell'oggetto e se la natura del contratto tra committente e datore di lavoro terzo è fittizia, il committente, non solo non potrà detrarre l'Iva, ma avrà anche l'obbligo di eseguire degli adempimenti fiscali in qualità di sostituto d'imposta.
Nel pervenire a tali conclusioni, è stato affermato che, in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, in caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalto di servizi, va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabile una prestazione dell'appaltatore imponibile ai fini IVA (Cass. civ., Sez. 5, n. 34876 del 17/11/2021).
Non sussiste infatti, nel caso di appalto non genuino, alcun valido contratto di appalto e il rapporto di somministrazione di lavoro, apparentemente instaurato con l'appaltatrice, è nullo con conseguente impossibilità di detrarre l'IVA da parte della società contribuente (Sez. 5, n. 12807 del 26/06/2020).
Sempre sul versante della giurisprudenza penale - sul presupposto dell'indetraibilità dell'Iva nei casi di illecita somministrazione di manodopera dissimulata da fittizi contratti di appalto e servizi - non si è mai dubitato del fatto che il delitto di frode fiscale D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 2 sia astrattamente configurabile nel caso di intermediazione illegale di manodopera.
Stante la diversità tra il soggetto emittente la fattura e quello che ha fornito la prestazione.
Da ciò discende pure la configurabilità del concorso di reati fra l’intermediazione illegale di mano d'opera (D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18) ed il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, nel caso di utilizzo di fatture rilasciate da una società che ha effettuato interposizione illegale di manodopera (Sez. 3, n. 20901 del 26/06/2020).
Ripercussioni della condotta sulla responsabilità dell’ente
ex D Lgs 231/2001
La contestazione della fattispecie di reato di cui all'art. 2 del D.lgs. 74/2000 può far scaturire un profilo di responsabilità penale anche in capo alle persone giuridiche con applicazione di sanzioni interdittive e patrimoniali di rilevante intensità (sia patrimoniale che afflittiva).
Infatti, la riforma del 2019 ha portato all'inserimento quali reati presupposto ai sensi del D.lgs. 231/2001 di molte delle fattispecie contemplate dal D.lgs. 74/2000 (il decreto sui reati tributari).
L’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ai sensi dell’art. 2 D Lgs 74/00 si configura quindi come reato presupposto per la responsabilità dell’ente ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.
Sul punto, le società e gli enti in generale sono chiamati a svolgere un’attività di compliance per mappare e tracciare tutte le aree sensibili in chiave preventiva in vista dell’adozione e adeguata implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.
Affinché un Modello Organizzativo sia elaborato, adottato ed aggiornato efficacemente, una organizzazione deve:
- effettuare una preliminare valutazione delle aree di rischio di commissione di illeciti (reati) nelle diverse aree di attività aziendale (sia quelle consolidate, che quelle in via di sviluppo);
- adottare un documento (codice etico) che detti un insieme di norme comportamentali che vincolano i soggetti operanti all'interno dell'ente, nonché gli operatori esterni che entrano in contatto con essa (per esempio, clienti, fornitori, agenti) i quali sono tenuti ad attenersi ad una condotta improntata alla trasparenza delle procedure e alla legalità;
- attivare procedure specifiche, in grado di gestire il rischio di commissione d’illeciti, prevenendo la messa in atto di specifici protocolli di prevenzione.
La Gestione del Rischio di Reato, attuata attraverso il Modello Organizzativo 231, è una attività di tipo preventivo: essa individua quelle aree aziendali in cui i dirigenti e/o i dipendenti potrebbero scegliere di agire nell’interesse o a vantaggio dell’azienda, commettendo illeciti e ledendo conseguentemente una serie di interessi diffusi e giuridicamente rilevanti (ad. es. la salute dei lavoratori, gli interessi e il patrimonio della Pubblica Amministrazione, la privacy di dipendenti o soggetti terzi, l’ambiente, i diritti umani, ecc…).
Nel caso che ci occupa, per prevenire l’illecito utilizzo di manodopera nell’accezione sopra indicata, dopo avere scrupolosamente verificato l’esistenza reale del fornitore, sarà necessario redigere idonei contratti di appalto nel pieno rispetto della normativa civilistica, giuslavoristica e dei principi elaborati dalla giurisprudenza; dovranno poi essere sottoposti ad attenta valutazione l’assunzione del personale da parte dell’appaltatore, il rapporto contrattuale con i dipendenti, la corretta e puntuale applicazione delle norme di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
Infine, vista la specificità della disciplina, è necessario per l’ente definire programmi di formazione dei dirigenti coinvolti nella specifica funzione al fine della corretta gestione dei processi sensibili.
In conclusione, è evidente quali siano i vantaggi di una corretta compliance finalizzata ad adottare modelli imprenditoriali virtuosi; il fine ultimo del Modello 231 è quello di evitare che la Società incorra in eventuali sanzioni a seguito della commissione di alcuno dei reati previsti dal D Lgs 231/01, tutelandone così anche l'immagine pubblica.
Il principale vantaggio dell’implementazione di un Modello 231 è infatti la sua funzione esimente, con riferimento alla responsabilità amministrativa della società stessa che lo ha adottato. In altri termini, in presenza di Modello 231 adottato e correttamente vigilato, la società risulterà estranea da responsabilità amministrativa/penale con risparmio delle pesantissime sanzioni sia di natura pecuniaria che interdittiva.
L’effetto diretto e immediato dell’adozione del modello è un maggior controllo, diffuso in tutto il personale dell’ente, dei processi sensibili e a rischio di reato.
L’effetto indiretto ma altrettanto importante è il contributo concreto alla diffusione della cultura della responsabilità e della prevenzione all’interno dell’ente e il relativo riflesso che ciò ha anche sull’immagine aziendale e sulla sua percezione da parte dei diversi portatori di interesse e dei terzi.
L’adeguamento alla norma può costituire l’occasione per rendere maggiormente virtuosa l’attività dell’ente e per rendere maggiormente visibile tale virtuosità.
Avv. Massimo Morelli